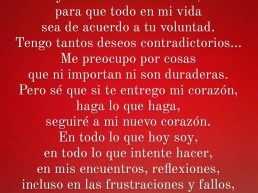Al termine di ogni tramonto milanese, goffo e punteggiato dai colori caldi, sparati e tossici del particolato atmosferico, l’arco di Porta Garibaldi si trasforma in un focolare ardente di fari elettrici e marmo.
Sorge tronfio e dorato all’incrocio di due vie continue: Corso Como e Corso Garibaldi. È un monumento storico, si è ritrovato in mezzo allo strepitio catartico e alcolico dell’aperitivo milanese.
Con vanità e seduzione griffata, mentre alcol annacquato e rincarato dalla location dei bar lubrifica le interazioni vere o finte. Le due strade si allungano nel ventre arricchito della metropoli, si affossano nella tana da cui spuntano le stazioni contigue di treni e metro.
Ed è in fondo alla fossa ferroviaria che l’universo umano si riannoda su sé stesso, si espande nel gioco dell’irresistibile piccolo orrore cittadino. Nella stazione, in basso, al fondo, si accumula ciò che resta, ciò che non ha imparato a scorrere.
Tra le porte di vetro inforcate da milioni di pendolari incazzati con Trenord, sotto una tettoia che miracolosamente sovrasta e sbalza di decine di metri il marciapiede sottostante, si apre un tavolo. Un doppio tavolo di plastica, con le gambe di alluminio incernierate alla base di plastica bianca e graffiata. E sopra il tavolo compare un trionfo alimentare, una sequenza interminabile di pesce, pasta, polenta, minestra serviti in piatti di plastica o racchiuse in vaschette di alluminio, panini e merendine, thermos di tè caldo, acqua e caffè. Dietro, i volontari in opera logistica, che approntano e preparano e distribuiscono.
Di lato, la fila è già plasmata. Abiti stazzonati, unghie arcuate come certi sorrisi e una overture di parole pronte a lanciarsi nella sinfonia del vivere. Davanti… noi.

Qualche settimana fa, due amici mi proposero di partecipare alla distribuzione del cibo organizzato da Bocatas. Lo fanno ogni venerdì, 21.30, stazione di Milano Porta Garibaldi. Puoi mangiare gratis, una volta a settimana, chiunque tu sia, qualunque sia il tuo curriculum di sfighe e colpe.
Cinquanta metri più in là puoi prendere un Gin&Tonic con chili di ghiaccio a tredici euro.
Chiesi se avessi dovuto portare qualcosa, mi risposero che non era importante, anzi che il cibo era secondario. Non ci avrei messo molto a capire il perché.
Ci sono molti volontari, moltissimi, più di quelli necessari alla logistica della distribuzione. Credo all’incirca tre volte tanto. Un sacco di ragazzi e ragazze, zainetti dalle cerniere lucenti e soprabiti lisci. Cosa facciamo adesso? Come funziona?
Sono arrivato prima dei miei amici e ciondolo in imbarazzata solitudine inutile per qualche minuto, mentre li aspetto.
Ed eccoli sul bordo della strada, appena scesi dalla macchina: stanno parlando con Bombolo. Un uomo meravigliosamente grasso, con un enorme giubbotto giallo dalle maniche strappate e ricucite, e una voce grattata dal sottosuolo. Sta imitando un attore. E poi un altro, e poi un politico, e un cantante.
È una rivelazione cabarettiana a pochi metri dalla metro. Non si stacca dai miei amici, ovviamente li conosce da prima, e parla. Parla. Parla. Arrivano altre persone, altre barbe e facce più o meno pulite. Incitano e spronano Bombolo a continuare, si uccidono tutti dal ridere mentre cambia registro vocale in meno di un secondo, sembra abbia un menu a tendina in bocca con le parti da recitare.
La folla aumenta, tutti che presentano tutti, mani e abbracci scambiati senza alcun ritmo. Non ci sono pettorine o bandiere, rischi addirittura di non distinguere i volontari dai cosiddetti bisognosi. Sembra assurdo, ma se qualcuno ha avuto la fortuna di essersi lavato in giornata e di indossare abiti non particolarmente logori, di taglia accettabile, la confusione può protrarsi per qualche imbarazzante minuto.
Poi le distinzioni vengono fuori. Le cuciture troppo tirate, quel sacchetto di plastica pieno di cibo forse un po’ vecchiotto, mani gonfie e fredde. Tutto il pacchetto di differenze tra chi può farsi una doccia nel proprio bagno e cambiarsi le mutande ogni maledetto giorno, e chi no. Tuttavia, le parole, la confusione, le luci elettriche e la stanchezza di fine giornata creano una amalgama non omogenea ma ben distribuita.
È voluto ovviamene, è organizzato così, come una piccola festa di amici che mangiano, chiacchierano, vivono. Le conversazioni esplodono in tutte le direzioni, per pochi secondi o per intere ore.
C’è questa coppia, lui ha un cane, lei ha un giubbotto nero un po’ largo e non le piace. E vuole delle scarpe nuove, quelle che ha le fanno male ai piedi. E deve essere tutto nero, non le piacciono le cose chiare. E vuole un intimo di un certo tipo, questo lo dice in privato a Cecilia.
Mi accorgo di non riuscire a definire una reazione, un modello di sensazione “esatto”. Tutti hanno il diritto di volere qualcosa di bello, di stare bene anche per un solo frammento di giornata.
Cosa cambia tra procurarle un giubbotto bianco o uno nero? Però ti chiedi cosa cambi per lei: non è importante semplicemente che stia al caldo? Non è importante la “sopravvivenza e basta” quando sei scivolato sul dorso e non puoi più camminare? Ovviamente no.
Perché lo sappiamo bene che a nessuno basta mai sopravvivere, anche se non mangia da giorni. Perché la gratitudine per qualcosa di ricevuto si accompagna sempre col desiderio di avere qualcosa d’altro, e solo perché si esterna un singolo moto del cuore, la sua controparte è sempre lì, accesa, inondante di luce.
Quella signora, quella ragazza, così mora e così agitata, si esprime con rabbia, con fastidiosa insistenza, e non si appiccica al modello di pietà o gentilezza. Ma da quando in qua chi risulta antipatico ha meno freddo, ha meno fame, ha meno voglia di parlare e di un vestito che le stia bene?
Mi presentano Mattia, un ragazzo di ventinove anni. Riccio, non grasso ma ben piazzato. Non ha casa da due mesi, la sua storia è un lavoro perso, un affitto non pagato, una famiglia scomparsa. È vero, non è vero, è vero in parte, è importante? Comincia a parlare. A me, a Roberto, a Cecilia. Loro due reagiscono e rispondo, scherzano, io nel mio imbarazzo mi limito ad annuire. Penso che dovrei fare di più, loro sono qui per mangiare e per parlare, io non ho portato cibo e manco riesco a sostenere una conversazione. Mi accorgo che non è particolarmente importante. Mi accorgo che non c’è alcuna conversazione. Non si incatenano argomenti ribalzati da una parte all’altra, non c’è logica, per quanto complicata, catalizzata dall’altrui risposta.
C’è solo una sassaiola. Una tempesta, una slavina, un fiume, un uragano, qualsiasi metafora o similitudine di “evento naturale inarrestabile” va bene. Mattia parla, parla, parla. Vorrebbe trovare un lavoro, lui è un muratore, un aggiustatutto, ma non lo assumono. Deve aggiornare il CV ma non ha ovviamente un pc e il cellulare è tutto rotto. Ha trovato un posto dove devi prenotarti ma ti puoi fare una doccia e ti danno intimo pulito. E c’è anche la tv. Lui cammina tutto il giorno, anche se gli fanno male i piedi lui cammina. Cerca di farsi una doccia una volta ogni due giorni. Mette sempre il giornale sotto il sacco a pelo. Ascolta la musica classica prima di addormentarsi. Non beve. No beh, un giorno a settimana va a prendersi una bottiglia di vino, una volta ha bevuto sedici birre da trentatrè. Parla e parla e disquisisce e pontifica e scherza, e ironizza. E si lamenta, ed è nostalgico. Mille discorsi pieni di abbandoni e contraddizioni. Di giorni e giorni in silenzio, o a parlare solo con un suo amico tunisino, che non capisce bene l’italiano e la conversazione incespica. Mattia ha una dizione da doppiatore, non ha mai sbagliato un maledetto congiuntivo in due ore di monologo quasi ininterrotto. Non so come sia possibile. Si scusa per aver parlato troppo, ma ne ha bisogno.
Hanno bisogno di tutto. Di una voce, di una battuta, di una risata. Di non essere compatiti, di un paio di calzini puliti. Di essere utili, di non dare fastidio, di esistere, di rispetto, di pietà, di consapevolezza, di pregare, di non dover pregare, di comunità, di amicizia, di solitudine.
Hanno tutti i bisogni dell’umanità, e non possono, non vogliono, non riescono ad offrire quanto noi offriamo alla società per avere le stesse identiche maldette cose. Vizi. Necessità. Rapporti. Hanno le loro colpe, hanno le loro sfighe.
Puoi cavartela con l’aiuto materiale, puoi mettere nei loro sacchetti di plastica qualche banconota strappata da un aperitivo. Mentre realizzi della stupidità di discorsi come “devono cavarsela da soli, dobbiamo creare opportunità e non tamponare ferite con la pietà” sono pura presunzione, pura auto assoluzione. E puoi passare del tempo con loro. Se ci riesci, se ce la fai.
Perché devi immergerti in tutto quello schifo, e nessun discorso di colpa e merito ti salva. In conversazioni su quale anfratto della stazione è più pulito e libero da topi e merda. In discorsi sul sentirsi in colpa nel rubare un salame da un euro e mezzo. In discorsi su chi ruba giubbotti da trecento euro per comprarsi l’eroina. In cose che esistono e marciscono nelle fondamenta del mondo da milioni di vite, e che non puoi cambiare se non di una frazione.
Puoi solo ascoltare.
Valerio / gennaio 2020